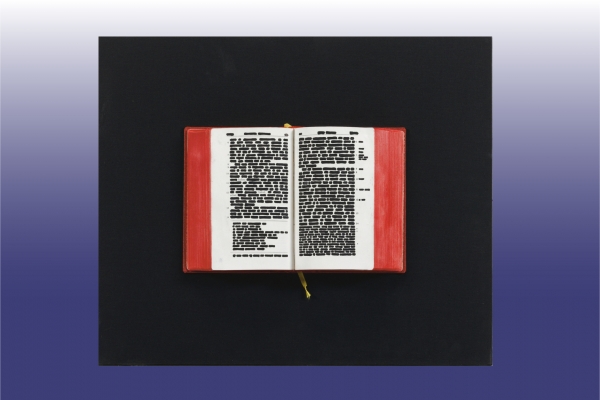Tema vasto quello dei DSM (ovvero le varie edizioni del Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali prodotte dall’American Psychiatric Association), necessariamente da sintetizzare, evidenziandone il retroterra metodologico e presentandone origine e implicazioni filosofiche. Dei cinque DSM il corso accenna inizialmente al primo e al secondo rispettivamente del 1952 e del 1968 – piccoli manuali privi di criteri diagnostici, quindi di scarsa importanza – focalizzandosi sulla rivoluzione del terzo, il DSM-III del 1980. Un manuale che si è imposto quale strumento di lavoro sia tra i clinici e che tra i ricercatori superando come importanza l’ICD (ovvero l’International Classification of Diseases) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Il DSM-5 continua a seguire le caratteristiche principali imposte negli anni Settanta da Robert Spitzer con il DSM-III, introdotto proprio da Paolo Migone, in anteprima per l’Italia, sulle pagine della rivista Psicoterapia e Scienze Umane (dove ha presentato anche i successivi DSM e i due PDM, cioè le due prime edizioni del Manuale Diagnostico Psicodinamico). Il DSM-III è stato il primo ad adottare un criterio non teorico ma descrittivo, che consiste non nel cogliere le cause della malattia, ma nel descrivere i sintomi così come li vede il clinico: così facendo Spitzer superava lo scoglio delle diverse teorie che impediva ai clinici di trovare un accordo sul metodo diagnostico. Tra le ragioni del DSM-III e dei successivi manuali vi era infatti il salvataggio della psichiatria dalla crisi dell’attendibilità delle diagnosi. Era noto, infatti, che prima del DSM-III risultava che ad esempio vi fossero maggiori diagnosi di schizofrenia negli Stati Uniti che in Europa, ed è stato possibile dimostrare che questa differenza non era epidemiologica ma diagnostica, cioè dovuta a diversi criteri per fare diagnosi.
Ma quali sono i problemi dell’approccio descrittivo? Il più evidente è che il criterio descrittivo ha paradossalmente allontanato la psichiatria dalla medicina, che segue invece criteri eziopatogenetici, ovvero centrati sul rapporto causa/cura. Migone mette poi in luce alcune dicotomie dei DSM.
La prima dicotomia, politetico/monotetico, è riferita ai criteri diagnostici. Il criterio politetico si basa sull’elenco di alcuni criteri diagnostici, alcuni dei quali devono essere presenti, non importa quali, basta un numero minimo. I criteri hanno infatti lo stesso valore ponderale: perché la diagnosi sia soddisfatta conta il loro numero (ad esempio almeno 5 criteri su 9). Questa “democrazia” dei criteri diagnostici è davvero problematica, perché implica che criteri molto diversi tra loro siano uguali, ignorando il fatto che alcuni possono essere la causa della malattia, altri la sua conseguenza. Il criterio monotetico invece presuppone che alcuni criteri siano più importanti di altri, ad esempio uno di essi deve necessariamente essere sempre presente per fare diagnosi, il che potrebbe avere implicazioni per l’eziologia. Ed è questo il motivo per cui Spitzer ha sposato il criterio politetico e non quello monotetico, allontanando però in questo modo la psichiatria dalla medicina che adotta il criterio monotetico, il quale potenzialmente lega maggiormente i sintomi delle malattie alla loro eziopatogenesi. La sua scelta è dovuta al fatto che spesso in psichiatria non si conosce la causa esatta delle malattie: si possono solo postulare cause a seconda della teoria adottata. Quanto alla debolezza del criterio politetico, non riuscendo a fare diagnosi con validità di costrutto ma solo attendibili, alta risulta la comorbilità (specie nelle diagnosi dei disturbi di personalità), fattore che invalida la diagnosi stessa in quanto se ne producono diverse parallele.
La seconda dicotomia, validità/attendibilità, è collegata alla prima perché una diagnosi descrittiva (e per di più basata su criteri politetici) può innalzare solo l’attendibilità, non la validità. Gli indici di validità e di attendibilità devono essere tenuti in un equilibro che in psichiatria è molto delicato.
La terza dicotomia è categorie/dimensioni. Le diagnosi categoriali presuppongono categorie, cioè malattie ideali che in tale forma nessun paziente possiede. L’approccio dimensionale, dove le dimensioni sono i tratti o le caratteristiche di un paziente, è più complesso ma è il preferito dagli psicologi e dai ricercatori, mentre i medici in genere prediligono quello categoriale perché è più pratico, permettendo ad esempio di scrivere una diagnosi sulla cartella clinica. Nell’approccio dimensionale non si diagnostica se un tratto c’è o non c’è, ma lo si studia lungo un continuum (ad esempio l’umore, o l’ansia) utilizzando scale di valutazione che vanno da un minimo a un massimo. Il modello dimensionale non fu usato nei DSM-III e DSM-IV perché difficile da gestire: infatti al clinico servono etichette (ovvero diagnosi) per cui la sua preferenza va all’approccio categoriale. Ma si può osservare che l’approccio dimensionale, in una certa misura, è presente anche in quello categoriale in quanto un paziente può soddisfare più o meno criteri, quindi si possono contare, il che potrebbe implicare una maggiore o minore gravità. Le categorie sono più astratte ma attraverso determinate scale possiamo misurare la distanza tra il prototipo, cioè la categoria, e il paziente reale. Riassumendo: il modello categoriale è più facile da usare, sebbene rischi di etichettare i pazienti, mentre quello dimensionale è più complesso nella sua applicazione clinica ma più utile per la ricerca e più aderente alla realtà clinica.
Il DSM-III e il DSM-IV hanno adottato il sistema multiassiale, poi espunto dal DSM-5. Tale sistema prevedeva che un paziente fosse visto attraverso cinque prospettive simultanee, le più importanti delle quali sono l’Asse I, per i disturbi clinici, e l’Asse II, per i disturbi di personalità. In un certo senso, si potrebbe dire che l’Asse I riguardi gli “stati” e l’Asse II i “tratti”, che sono dimensioni stabili: generalmente si formano nell’adolescenza e persistono per tutta la vita anche se possono essere in una certa misura modificati dagli eventi di vita e anche dall’intervento psicoterapeutico. I due assi si condizionano reciprocamente. Il sistema multiassiale è stato eliminato dal DSM-5: tale decisione è stata giustificata in base all’assenza di Assi nell’ICD, ovvero l’International Classification of Diseases dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Gli Assi consentivano di comprendere meglio il quadro clinico, perché ad esempio nell’Asse III venivano elencati di disturbi medici, nell’Asse IV i fattori psicosociali stressanti e nell’Asse V il funzionamento psicosociale, per cui in un certo qual modo si poteva tentare di comprendere il paziente da un punto di vista psicodinamico, o almeno da più punti di vista, anche psicosociali.
Vi era l’aspettativa che il DSM-5 riuscisse a superare la crisi dei DSM. Il tentativo di Spitzer di raggiungere non solo l’attendibilità ma anche la validità è fallito, e la comorbilità si è rivelata il tallone di Achille dei DSM. Per risolvere tale impasse il DSM-5 ha introdotto maggiormente l’approccio dimensionale come uno dei modi di parare le critiche sempre più frequenti al modello categoriale, introducendo ad esempio la necessità che in determinate diagnosi alcuni criteri diagnostici fossero sempre presenti.
Nella sezione sui disturbi di personalità, che costituiva una delle parti più deboli dei DSM-III e DSM-IV, nel DSM-5 si è formulato un nuovo modello dimensionale, basato su una accuratissima ricerca. Ma alla votazione dei garanti, pochi giorni prima della pubblicazione del manuale, tale sistema venne escluso perché troppo complesso e faticoso da applicare, e si temeva che tale complessità potesse incidere sulle vendite del manuale. Non si poté fare altro allora che reintrodurre nel DSM-5 tutte le precedenti diagnosi di personalità del DSM-IV, con i relativi problemi di validità; si aggiunse solo una diagnosi, un disturbo di personalità dovuto a un fattore organico, ad esempio a un tumore cerebrale.
Altre novità del DSM-5 sono l’introduzione del concetto dimensionale di “spettro” applicato a vari disturbi, per esempio all’autismo, e l’abbassamento delle soglie per formulare la diagnosi. Come molti autori critici hanno fatto notare, questo abbassamento delle soglie implica un aumento di diagnosi con un conseguente maggiore uso di farmaci nella popolazione, a vantaggio delle case farmaceutiche. Si è anche formato un movimento internazionale di boicottaggio del DSM-5, al quale hanno partecipato anche i capi delle task force dei due precedenti DSM. Il movimento in certe sue frange estremiste si è poi trasformato in una campagna contro la diagnosi in quanto tale, e quindi ha perso la sua efficacia nell’incidere sulle scelte del DSM-5; a quel punto Allen Frances, capo della task force del DSM-IV, comprensibilmente decise di ritirare la sua adesione a questo movimento.
Nella conclusione del corso si accenna al “modello alternativo” dei disturbi di personalità, scartato dal manuale ma comunque pubblicato in una sezione a parte; è basato su cinque dimensioni, che fanno capo a due dimensioni sovraordinate che si riferiscono – per riprendere gli studi di Sid Blatt che hanno avuto una certa influenza sulla costruzione di questo modello – ai concetti di “autonomia” (definizione del Sé) e di “dipendenza” (relazione con le altre persone). A questo proposito si accenna a questa polarità fondamentale della personalità, che presenta aspetti interessanti anche dal punto di vista psicodinamico.
Per un trattamento più approfondito sui DSM si può consultare il cap. 12 del libro di Paolo Migone, Terapia psicoanalitica. Seminari, FrancoAngeli, 1995, 2010 (www.francoangeli.it/ricerca/scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1250.8), e il suo articolo “Presentazione del DSM-5” nel n. 4/2013 della rivista Psicoterapia e Scienze Umane (www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=49900&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=34).